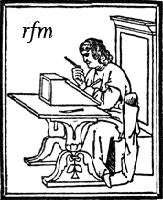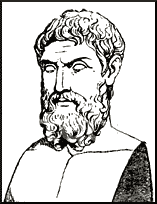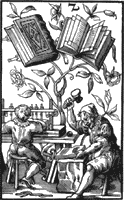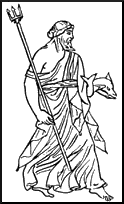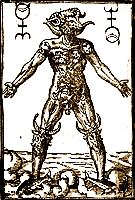Niccolò Machiavelli L’Asino
Machiavelli L’Asino
Capitolo primo ⮵
I vari casi, la pena e la doglia
che sotto forma d’un Asin soffersi,
canterò io, pur che fortuna voglia.
Non cerco ch’Elicona altr’acqua versi,
o Febo posi l’arco e la faretra
e con la lira accompagni i miei versi;
sì perché questa grazia non s’impetra
in questi tempi, sì perch’io son certo
ch’al suon d’un raglio non bisogna cetra.
Né cerco averne prezzo, premio o merto;
e ancor non mi curo che mi morda
un detrattore, o palese o coperto;
ch’io so ben quanto gratitudo è sorda
a’ preghi di ciascuno, e so ben quanto
de’ benificii un Asin si ricorda.
Morsi o mazzate io non istimo tanto
quanto io soleva, sendo divenuto
de la natura di colui ch’io canto.
S’io fossi ancor di mia prova tenuto
più ch’io non soglio, così mi comanda
quell’Asin sott’il quale io son vissuto.
Volse già farne un bere in fonte Branda
ben tutta Siena; e poi gli mise in bocca
una gocciola d’acqua a randa a randa.
Ma se ’l ciel nuovi sdegni non trabocca
contra di me, e’ si farà sentire
per tutto un raglio, e sia zara a chi tocca.
Ma prima ch’io cominci a riferire
dell’Asin mio i diversi accidenti,
non vi rincresca una novella udire.
Fu, e non sono ancora al tutto spenti
i suoi consorti un certo giovanetto
pure in Firenze infra l’antiche genti.
A costui venne crescendo un difetto:
ch’in ogni luogo per la via correva,
e d’ogni tempo senza alcun rispetto.
E tanto il padre vie più si doleva
di questo caso, quanto le cagioni
de la sua malattia men conosceva;
e volse intender molte opinioni
di molti savi, e ’n più tempo vi porse
mille rimedi di mille ragioni.
Oltra di questo, anco e’ lo botò forse;
ma ciascadun rimedio ci fu vano,
perciò che sempre, e in ogni luogo corse.
Ultimamente un certo cerretano,
de’ quali ogni dì molti ci si vede,
promise al padre suo renderlo sano.
Ma, come avvien che sempre mai si crede
a chi promette il bene (onde deriva
ch’a’ medici si presta tanta fede:
e spesso lor credendo, l’uom si priva
del bene: e questa sol tra l’altre sètte
par che del mal d’altrui si pasca e viva),
così costui niente in dubbio stette,
e ne le man gli mise questo caso;
ch’a le parole di costui credette.
Ed ei gli fe’ cento profumi al naso;
tràssegli sangue de la testa; e poi
gli parve aver il correr dissuaso.
E fatto ch’ebbe altri rimedi suoi,
rendé per sano al padre il suo figliuolo,
con questi patti ch’or vi direm noi:
che mai non lo lasciasse andar fuor solo
per quattro mesi, ma con seco stesse
chi, se per caso e’ si levasse a volo,
che con qualche buon modo il ritenesse,
dimostrandogli in parte il suo errore,
pregandol ch’al suo onor riguardo avesse.
Così andò ben più d’un mese fòre
onesto e saggio, infra due suoi fratelli,
di reverenza pieno e di timore;
ma giunto un di’ ne la via de’ Martelli,
onde puossi la via Larga vedere,
cominciaro arricciarsigli i capelli.
Non si poté questo giovin tenere,
vedendo questa via dritta e spaziosa,
di non tornar ne l’antico piacere;
e, posposta da parte ogni altra cosa,
di correr gli tornò la fantasia,
che mulinando mai non si riposa;
e giunto in su la testa de la via
lasciò ire il mantello in terra, e disse:
— Qui non mi terrà Cristo; — e corse via.
E di poi corse sempre, mentre visse,
tanto che ’l padre si perdé la spesa
e ’l medico lo studio che vi misse.
Perché la mente nostra, sempre intesa
dietro al suo natural, non ci consente
contr’abito o natura sua difesa.
Ed io, avendo già volta la mente
a morder questo e quello, un tempo stetti
assai quieto, umano e paziente,
non osservando più gli altrui difetti,
cercando in altro modo fare acquisto;
tal che d’esser guarito i’ mi credetti.
Ma questo tempo dispettoso e tristo
fa, senza ch’alcuno abbia gli occhi d’Argo,
più tosto il mal che ’l bene ha sempre visto;
onde s’alquanto or di veleno spargo,
bench’io mi sia divezzo di dir male,
mi sforza il tempo di materia largo.
E l’Asin nostro che per tante scale
di questo nostro mondo ha mossi i passi,
per lo ingegno veder d’ogni mortale,
se bene in ogni luogo si osservassi
per le sue strade i suoi lunghi cammini,
non lo terrebbe il ciel che non ragghiassi.
Dunque, non fie verun che s’avvicini
a questa rozza e capitosa gregge,
per non sentir degli scherzi asinini:
ch’ognun ben sa, che sua natura legge,
ch’un de’ più destri giuochi che far sappi
è trarre un paio di calci e due corregge.
E ognuno a suo modo ciarli e frappi
e abbia quanto voglia e fumo e fasto,
ch’omai convien che questo Asin ci cappi;
e sentirassi come il mondo è guasto,
perch’io vorrò che tutto un vel dipinga,
avanti che si mangi il freno e ’l basto:
e chi lo vuol aver per mal, si scinga.
Capitolo secondo ⮵
Quando ritorna la stagione aprica,
allor che primavera il verno caccia,
a’ ghiacci, al freddo, a le nevi nimica,
dimostra il cielo assai benigna faccia,
e suol Diana con le Ninfe sue
ricominciar pe’ boschi andar a caccia;
e ’l giorno chiaro si dimostra piue,
massime se, tra l’uno e l’altro corno
il sol fiammeggia del celeste bue.
Sentonsi gli asinelli, andando attorno,
romoreggiar insieme alcuna volta
la sera, quando a casa fan ritorno;
tal che chiunque parla, mal si ascolta;
onde che per antica usanza è suta
dire una cosa la seconda volta;
perché con voce tonante e arguta
alcun di loro spesso o raglia o ride,
se vede cosa che gli piaccia, o fiuta.
In questo tempo, allor che si divide
il giorno da la notte, io mi trovai
in un luogo aspro quanto mai si vide.
Io non vi so ben dir com’io v’entrai,
né so ben la cagion perch’io cascassi
là dove al tutto libertà lasciai.
Io non poteva muover i miei passi
pe ’l timor grande e per la notte oscura,
ch’io non vedeva punto ov’io m’andassi.
Ma molto più mi accrebbe la paura
un suon d’un corno sì feroce e forte,
ch’ancor la mente non se ne assicura.
E mi parea veder intorno Morte
con la sua falce, e d’un color dipinta
che si dipinge ciascun suo consorte.
L’aria di folta e grossa nebbia tinta,
la via di sassi, bronchi e sterpi piena
avean la virtù mia prostrata e vinta.
A un troncon m’er’io appoggiato a pena,
quando una luce subito m’apparve
non altrimenti che quando balena;
ma come il balenar già non disparve,
anzi, crescendo e venendomi presso,
sempre maggiore e più chiara mi parve.
Aveva io fisso in quella l’occhio messo,
e intorno a essa un mormorio sentivo
d’un frascheggiar, che le veniva appresso.
Io ero quasi d’ogni senso privo,
e, spaventato a quella novitate,
teneva vòlto il volto a ch’io sentivo,
quando una donna piena di beltade,
ma fresca e frasca, mi si dimostrava
con le sue trecce bionde e scapigliate.
Con la sinistra un gran lume portava
per la foresta, e da la destra mano
teneva un corno con ch’ella sonava.
Intorno a lei, per lo solingo piano,
erano innumerabili animali,
che dietro le venian di mano in mano.
Orsi, lupi e leon fieri e bestiali,
e cervi e tassi e, con molte altre fiere,
uno infinito numer di cignali.
Questo mi fece molto più temere,
e fuggito sarei pallido e smorto,
s’aggiunto fosse a la voglia il potere.
Ma quale stella m’avria mostro il porto?
E dove gito, misero, sarei?
O chi m’avrebbe al mio sentiere scòrto?
Stavano dubbi tutti i pensier miei,
s’io doveva aspettar ch’a me venisse,
o reverente farmi incontro a lei;
tanto ch’innanzi dal tronco i’ partisse,
sopragiunse ella, e con un modo astuto
e sogghignando: — Buona sera — disse.
E fu tanto domestico il saluto,
con tanta grazia, con quanta avria fatto,
se mille volte m’avesse veduto.
Io mi rassicurai tutto a quello atto;
e tanto più chiamandomi per nome
nel salutar che fece il primo tratto.
E di poi, sogghignando, disse: — Or come,
dimmi, sei tu cascato in queste valle
da nullo abitator colte né dome?
Le guance mie, ch’erano smorte e gialle,
mutar colore e diventar di fuoco,
e tacendo mi strinsi ne le spalle.
Arei voluto dir: — Mio senno poco,
vano sperare e vana openione
m’han fatto ruinare in questo loco; —
ma non potei formar questo sermone
in nessun modo, cotanta vergogna
di me mi prese, e tal compassione.
Ed ella sorridendo: — E’ non bisogna
tu tema di parlar tra questi ceppi;
ma parla, e di’ quel che ’l tuo core agogna;
ché, benché in questi solitari greppi
i’ guidi questa mandra, e’ son più mesi
che tutto ’l corso di tua vita seppi.
Ma perché tu non puoi aver intesi
i casi nostri, io ti dirò in che lato
ruinato tu sia, o in che paesi.
Quando convenne, nel tempo passato,
a Circe abbandonar l’antico nido,
prima che Giove prendesse lo stato,
non ritrovando alcuno albergo fido,
né gente alcuna che la ricevesse,
tanto era grande di sua infamia il grido,
in queste oscure selve, ombrose e spesse,
fuggendo ogni consorzio umano e legge,
suo domicilio e la sua sedia messe.
Tra queste, adunque, solitarie schegge
agli uomini nimica, si dimora,
nodrita da’ sospir di questa gregge.
E perché mai alcun non uscì fuora,
che qui venisse, però mai novelle
di lei si sepper, né si sanno ancora.
Sono al servizio suo molte donzelle,
con le quai solo il suo regno governa,
ed io sono una del numer di quelle.
A me è dato per faccenda eterna,
che meco questa mandria a pascer venga
per questi boschi, e ogni lor caverna.
Però convien che questo lume tenga
e questo corno: l’uno e l’altro è buono,
s’avvien che ’l giorno, ed io sia fuor, si spenga.
L’un mi scorge il cammin; con l’altro i’ suono
s’alcuna bestia nel bosco profondo
fosse smarrita, sappia dove i’ sono.
E se mi domandassi, io ti rispondo:
sappi che queste bestie che tu vedi,
uomini, come te, furon nel mondo.
E s’a le mie parole tu non credi,
risguarda un po’ come intorno ti stanno,
e chi ti guarda e chi ti lecca i piedi.
E la cagion del guardar ch’elle fanno
è ch’a ciascuna de la tua ruina
rincresce, e del tuo male e del tuo danno.
Ciascuna, come te, fu peregrina
in queste selve, e poi fu trasmutata
in queste forme da la mia regina.
Questa propria virtù dal ciel gli è data,
che in varie forme faccia convertire
tosto che ’l volto d’un uom fiso guata.
Per tanto a te convien meco venire
e di questa mia mandra seguir l’orma,
se in questi boschi tu non vuoi morire.
E perché Circe non vegga la forma
del volto tuo, e per venir secreto,
te ne verrai carpon fra questa torma.
Allor si mosse con un viso lieto;
e io, non ci veggendo altro soccorso,
carpendo con le fiere le andai drieto,
infra le spalle d’un cervio e d’un orso.
Capitolo terzo ⮵
Dietro a le piante de la mia duchessa
andando, con le spalle volto al cielo,
tra quella turba d’animali spessa,
or mi prendeva un caldo ed or un gelo,
or le braccia tremando mi cercava
s’elle avevan cangiato pelle o pelo.
Le mani e le ginocchia io mi guastava;
o voi ch’andate a le volte carponi,
per discrezion pensate com’io stava.
Er’ito forse un’ora ginocchioni
tra quelle fiere, quando capitamo
in un fossato tra duo gran valloni.
Vedere innanzi a noi non potevamo,
però che il lume tutti ci abbagliava
di quella donna che noi seguavamo;
quando una voce udimmo che fischiava
col rumor d’una porta che si aperse,
di cui l’uno e l’altro uscio cigolava.
Come la vista el riguardar sofferse,
dinanzi agli occhi nostri un gran palazzo
di mirabile altura si scoperse.
Magnifico e spazioso era lo spazzo;
ma bisognò, per arrivare a quello,
di quel fossato passar l’acqua a guazzo.
Una trave faceva ponticello
sopra cui sol passò la nostra scorta,
non potendo le bestie andar sopr’ello.
Giunti che fummo a piè de l’alta porta,
pien d’affanno e d’angoscia i’ entrai drento,
tra quella turba ch’è peggio che morta,
e fummi assai di minore spavento;
ché la mia donna perch’io non temessi,
avea ne l’entrar quivi il lume spento.
E questo fu cagion ch’io non vedessi
d’onde si fosse quel fischiar venuto,
o chi aperto ne l’entrar ci avessi.
Così tra quelle bestie sconosciuto,
mi ritrovai in un ampio cortile,
tutto smarrito, senza esser veduto.
E la mia donna bella, alta e gentile,
per ispazio d’un’ora, o più, attese
le bestie a rassettar nel loro ovile.
Poi tutta lieta per la man mi prese,
ed in una sua camera menommi,
dov’un gran fuoco di sua mano accese;
col qual cortesemente rasciugommi
quell’acqua che m’avea tutto bagnato,
quando il fossato passar bisognommi.
Poscia ch’io fui rasciutto, e riposato
alquanto da l’affanno e dispiacere
che quella notte m’avea travagliato,
incominciai: — Madonna il mio tacere
nasce non già perch’io non sappia a punto
quanto ben fatto m’hai, quanto piacere.
Io era al termin di mia vita giunto,
per luogo oscuro, tenebroso e cieco,
quando fui da la notte sopraggiunto.
Tu mi menasti per salvarmi teco:
dunque la vita da te riconosco
e ciò ch’intorno a quella porto meco.
Ma la memoria de l’oscuro bosco
col tuo bel volto m’han fatto star cheto
(nel qual ogni mio ben veggo e conosco),
che fatto m’hanno ora doglioso or lieto:
doglioso per quel mal che venne pria;
allegro per quel ben che venne drieto;
ché potuto non ho la voce mia
esplicar a parlare infin ch’io sono
posato in parte de la lunga via.
Ma tu, ne le cui braccia io m’abbandono,
e che tal cortesia usata m’hai,
che non si può pagar con altro dono,
cortese in questa parte ancor sarai,
che non ti gravi sì, che tu mi dica
quel corso di mia vita che tu sai — .
Tra la gente moderna e tra l’antica,
cominciò ella, — alcun mai non sostenne
più ingratitudin, né maggior fatica.
Questo già per tua colpa non ti avvenne,
come avviene ad alcun, ma perché sorte
al tuo ben operar contraria venne.
Questa ti chiuse di pietà le porte,
quando ch’al tutto questa t’ha condutto
in questo luogo sì feroce e forte.
Ma perché il pianto a l’uom fu sempre brutto,
si debbe a’ colpi de la sua fortuna
voltar il viso di lagrime asciutto.
Vedi le stelle e ’l ciel, vedi la luna,
vedi gli altri pianeti andar errando
or alto or basso senza requie alcuna;
quando il ciel vedi tenebroso, e quando
lucido e chiaro; e così nulla in terra
vien ne lo stato suo perseverando.
Di quivi nasce la pace e la guerra;
di qui dipendon gli odi tra coloro
ch’un muro insieme ed una fossa serra.
Da questo venne il tuo primo martoro;
da questo nacque al tutto la cagione
de le fatiche tue senza ristoro.
Non ha cangiato il cielo opinione
ancor, né cangerà, mentre che i fati
tengon ver te la lor dura intenzione.
E quelli umori i quai ti sono stati
cotanto avversi e cotanto nimici,
non sono ancor, non sono ancor purgati;
ma come secche fien le lor radici
e che benigni i ciel si mostreranno,
torneran tempi più che mai felici;
e tanto lieti e giocondi saranno,
che ti darà diletto la memoria
e del passato e del futuro danno.
Forse ch’ancor prenderai vanagloria
a queste genti raccontando e quelle
de le fatiche tue la lunga istoria.
Ma prima che si mostrin queste stelle
liete verso di te, gir ti conviene
cercando il mondo sotto nuova pelle;
ché quella Provvidenza che mantiene
l’umana spezie, vuol che tu sostenga
questo disagio per tuo maggior bene.
Di qui conviene al tutto che si spenga
in te l’umana effigie, e, senza quella,
meco tra l’altre bestie a pascer venga.
Né può mutarsi questa dura stella;
e, per averti in questo luogo messo,
si differisce il mal, non si cancella.
E lo star meco alquanto t’è permesso,
acciò del luogo esperienza porti,
e degli abitator che stanno in esso.
Adunque fa che tu non ti sconforti;
ma prendi francamente questo peso
sopra gli omeri tuoi solidi e forti;
ch’ancor ti gioverà d’averlo preso.
Capitolo quarto ⮵
Poi che la donna di parlare stette,
leva’mi in piè, rimanendo confuso
per le parole ch’ella aveva dette.
Pur dissi: — Il ciel né altri i’ non accuso,
né mi vo’ lamentar di sì ria sorte,
perché nel mal più che nel ben sono uso.
Ma s’io dovessi per l’infernal porte
gire al ben che detto hai, mi piacerebbe,
non che per quelle vie che tu m’hai porte.
Fortuna, dunque, tutto quel che debbe
e che le par, de la mia vita faccia;
ch’io so ben che di me mai non le ’ncrebbe. —
Allora la mia donna aprì le braccia,
e con un bel sembiante, tutta lieta,
mi baciò dieci volte e più la faccia;
poi disse festeggiando: — Alma discreta,
questo viaggio tuo, questo tuo stento,
cantato fia da istorico o poeta.
Ma perché via passar la notte sento,
vo’ che pigliam qualche consolazione
e che mutiam questo ragionamento.
E prima troverem da colezione,
ché so bisogno n’hai forse non poco,
se di ferro non è tua condizione;
e goderemo insieme in questo loco.
E detto questo, una sua tovaglietta
apparecchiò su un certo desco al fuoco.
Poi trasse d’uno armario una cassetta,
dentrovi pane, bicchieri e coltella,
un pollo, una insalata acconcia e netta,
e altre cose appartenenti a quella.
Poscia, a me volta, disse: — Questa cena
ogni sera m’arreca una donzella.
Ancor questa guastada porta piena
di vin, che ti parrà, se tu l’assaggi,
di quel che Val di Grieve e Poppi mena.
Godiamo, adunque; e, come fanno i saggi,
pensa che ben possa venire ancora;
e chi è dritto, al fin convien che caggi.
E quando viene il mal, che viene ognora,
mandalo giù come una medicina;
ché pazzo è chi la gusta o l’assapora.
Viviamo or lieti, infin che domattina
con la mia greggia sia tempo uscir fuori,
per ubbidire a l’alta mia regina — .
Così lasciando gli affanni e i dolori,
lieti insieme cenammo: e ragionossi
di mille canzonette e mille amori.
Poi, come avemmo cenato, spogliossi,
e dentro al letto mi fe’ seco entrare,
come suo amante o suo marito io fossi.
Qui bisogna a le Muse il peso dare,
per dir la sua beltà; ché senza loro
sarebbe vano il nostro ragionare.
Erano i suoi capei biondi com’oro,
ricciuti e crespi, tal che d’una stella
pareano i raggi o del superno coro.
Ciascuno occhio pareva una fiammella
tanto lucente, sì chiara e sì viva,
ch’ogni acuto veder si spegne in quella.
Avea la testa una grazia attrattiva,
tal ch’io non so a chi me la somigli,
perché l’occhio al guardarla si smarriva.
Sottili, arcati e neri erano i cigli,
perch’a plasmargli fur tutti gli dei,
tutti i celesti e superni consigli.
Di quel che da quei pende dir vorrei
cosa ch’al vero alquanto rispondesse,
ma tacciol, perché dir non lo saprei.
Io non so già chi quella bocca fesse;
se Giove con sua man non la fece egli,
non credo ch’altra man far la potesse.
I denti più che d’avorio eran begli;
e una lingua vibrar si vedeva,
come una serpe, infra le labbra e quegli:
d’onde uscì un parlare, il qual poteva
fermare i venti e far andar le piante,
sì soave concento e dolce aveva.
Il collo e ’l mento ancor vedeasi, e tante
altre bellezze, che farian felice
ogni meschino e infelice amante.
Io non so s’a narrarlo si disdice
quel che seguì da poi; però che ’l vero
suole spesso far guerra a chi lo dice.
Pur lo dirò, lasciandone il pensiero
a chi vuol biasimar; perché, tacendo
un gran piacer, non è piacer intero.
Io venni ben con l’occhio discorrendo
tutte le parti sue infino al petto,
a lo splendor del qual ancor m’accendo;
ma più oltre veder mi fu disdetto
da una ricca e candida coperta,
con la qual coperto era il picciol letto.
Era la mente mia stupida e incerta,
frigida, mesta, timida e dubbiosa,
non sapendo la via quanto era aperta.
E come giace stanca e vergognosa
e involta nel lenzuol, la prima sera,
presso al marito la novella sposa,
così d’intorno, pauroso, m’era
la coperta del letto inviluppata,
come quel che ’n virtù sua non ispera.
Ma poi che fu la donna un pezzo stata
a riguardarmi, sogghignando disse:
— Sare’ io d’ortica o pruni armata?
Tu puo’ aver quel che sospirando misse
alcun già, per averlo, più d’un grido,
e fe’ mille quistioni e mille risse.
Bene entreresti in qualche loco infido,
per ritrovarti meco, o noteresti
come Leandro infra Seto e Abido;
poi che la virtute hai sì poca, che questi
panni che son fra noi ti fanno guerra,
e da me sì discosto ti ponesti — .
E come quando nel carcer si serra,
dubbioso de la vita, un peccatore,
che sta con gli occhi guardando la terra;
poi, s’egli avvien che grazia dal signore
impetri, e’ lascia ogni pensiero strano
e prende assai d’ardire e di valore,
tal er’io, e tal divenni per l’umano
suo ragionare; e a lei m’accostai,
stendendo fra’ lenzuol la fredda mano.
E come poi le sue membra toccai,
un dolce sì soave al cor mi venne
qual io non credo più gustar mai.
Non in un loco la man si ritenne,
ma, discorrendo per le membra sue,
la smarrita virtù tosto rinvenne.
E non essendo già timido piue,
dopo un dolce sospir, parlando dissi:
— Sian benedette le bellezze tue!
Sia benedetta l’ora, quando io missi
il piè ne la foresta, e se mai cose,
che ti fossero a cor, feci né scrissi.
E pien di gesti e parole amorose,
rinvolto in quelle angeliche bellezze,
che scordar mi facean l’umane cose,
intorno al cor sentii tante allegrezze
con tanto dolce, ch’io mi venni meno
gustando il fin di tutte le dolcezze,
tutto prostrato sopra il dolce seno.
Capitolo quinto ⮵
Veniva già la fredda notte manco:
fuggivansi le stelle ad una ad una,
e d’ogni parte il ciel si facea bianco;
cedeva al sole il lume de la luna,
quando la donna mia disse: — E’ bisogna
poi ch’egli è tale il voler di Fortuna,
s’io non voglio acquistar qualche vergogna
tornar a la mia mandra, e menar quella
dove prender l’usato cibo agogna.
Tu ti resterai solo in questa cella,
e questa sera, al tornar, menerotti
dove tu possa a tuo modo vedella.
Non uscir fuor; questo ricordo dotti;
non risponder s’un chiama, perché molti
degli altri questo errore ha mal condotti.
Indi partissi; ed io, ch’aveva volti
tutti i pensieri a l’amoroso aspetto,
che lucea più che tutti gli altri volti,
sendo rimaso in camera soletto,
per mitigar, del letto i’ mi levai,
l’incendio grande che m’ardeva il petto.
Come prima da lei mi discostai,
mi riempié di pensier la saetta
quella ferita che per lei sanai.
E stav’io come quello che sospetta
di varie cose, e se stesso confonde,
desiderando il ben che non aspetta.
E perché a l’un pensier l’altro risponde
la mente a le passate cose corse,
che ’l tempo per ancor non ci nasconde;
e qua e là ripensando discorse,
come l’antiche genti, alte e famose,
fortuna spesso or carezzò e or morse;
e tanto a me parver maravigliose,
che meco la cagion discorrer volli
del variar de le mondane cose.
Quel che ruina da’ più alti colli,
più ch’altro, i regni, è questo: che i potenti
di lor potenza non son mai satolli.
Da questo nasce che son mal contenti
quei ch’han perduto, e che si desta umore
per ruinar quei che restan vincenti;
onde avvien che l’un sorge e l’altro muore;
e quel ch’è surto, sempre mai si strugge
per nuova ambizione o per timore.
Questo appetito gli stati distrugge:
e tanto è più mirabil, che ciascuno
conosce questo error, nessun lo fugge.
San Marco impetuoso ed importuno,
credendosi aver sempre il vento in poppa,
non si curò di ruinare ognuno;
né vide come la potenza troppa
era nociva, e come il me’ sarebbe
tener sott’acqua la coda e la groppa.
Spesso uno ha pianto lo stato ch’egli ebbe,
e, dopo il fatto, poi s’accorge come
a sua ruina e a suo danno crebbe.
Atene e Sparta, di cui sì gran nome
fu già nel mondo, allor sol ruinorno
quando ebber le potenze intorno dome.
Ma di Lamagna nel presente giorno
ciascaduna città vive sicura,
per aver manco di sei miglia intorno.
A la nostra città non fe’ paura
Arrigo già con tutta la sua possa,
quando i confini avea presso a le mura;
ed or ch’ella ha sua potenza promossa
intorno, e diventata è grande e vasta,
teme ogni cosa, non che gente grossa.
Perché quella virtute che soprasta
un corpo a sostener, quando egli è solo,
a regger poi maggior peso non basta.
Chi vuol toccar e l’uno e l’altro polo,
si truova ruinato in sul terreno,
com’Icar già dopo suo folle volo.
Vero è che suol durar o più o meno
una potenza, secondo che più
o men sue leggi buone e ordin fieno.
Quel regno che sospinto è da virtù
ad operare, o da necessitate,
si vedrà sempre mai gire all’insù;
e per contrario fia quella cittate
piena di sterpi silvestri e di dumi,
cangiando seggio dal verno a la state,
tanto ch’al fin convien che si consumi
e ponga sempre la sua mira in fallo,
che ha buone leggi e cattivi costumi.
Chi le passate cose legge, sallo
come gli imperii comincian da Nino,
e poi finiscono in Sardanapallo.
Quel primo fu tenuto un uom divino,
quell’altro fu trovato fra l’ancille
com’una donna dispensar il lino.
La virtù fa le region tranquille:
e da tranquillità poi ne risolta
l’ozio: e l’ozio arde i paesi e le ville.
Poi, quando una provincia è stata involta
ne’ disordini un tempo, tornar suole
virtute ad abitarvi un’altra volta.
Quest’ordine così permette e vuole
chi ci governa, acciò che nulla stia
o possa star mai fermo sotto ’l sole.
Ed è, e sempre fu e sempre fia
che ’l mal succeda al bene, il bene al male,
e l’un sempre cagion dell’altro sia.
Vero è ch’un crede sia cosa mortale
pe’ regni, e sia la lor distruzione
l’usura, o qualche peccato carnale;
e della lor grandezza la cagione,
e che alti e potenti gli mantiene,
sian digiuni, limosine, orazione.
Un altro, più discreto e savio, tiene
ch’a ruinargli questo mal non basti,
né basti a conservargli questo bene.
Creder che senza te per te contrasti
Dio, standoti ozioso e ginocchioni,
ha molti regni e molti stati guasti.
E’ son ben necessarie l’orazioni:
e matto al tutto è quel ch’al popol vieta
le cerimonie e le sue divozioni;
perché da quelle in ver par che si mieta
unione e buono ordine; e da quello
buona fortuna poi dipende e lieta.
Ma non sia alcun di sì poco cervello,
che creda, se la sua casa ruina
che Dio la salvi senz’altro puntello;
perché e’ morrà sotto quella ruina.
Capitolo sesto ⮵
Mentre ch’io stava sospeso ed involto
con l’affannata mente in quel pensiero,
aveva il sole il mezzo cerchio volto:
il mezzo, dico, del nostro emispero;
tal che da noi s’allontanava il giorno,
e l’oriente si faceva nero;
quando io conobbi pe ’l sonar d’un corno
e pe ’l ruggir de l’infelice armento,
come la donna mia facea ritorno.
E bench’io fossi in quel pensiero intento
che tutto il giorno a sé mi aveva tratto,
e del mio petto ogni altra cura spento,
com’io sentii la mia donna, di fatto
pensai ch’ogni altra cosa fosse vana
fuor di colei di cui fui servo fatto;
che, giunta dov’io era, tutta umana
il collo mio con un de’ bracci avvinse,
con l’altro mi pigliò la man lontana.
Vergogna alquanto il viso mi dipinse,
né potti dire alcuna cosa a quella,
tanta fu la dolcezza che mi vinse.
Pur, dopo alquanto spazio, e io ed ella
insieme ragionammo molte cose,
com’uno amico con l’altro favella.
Ma, riposate sue membra angosciose
e recreate dal cibo usitato,
così parlando la donna propose:
Già ti promisi d’averti menato
in loco dove comprender potresti
tutta la condizion del nostro stato;
adunque, se ti piace, fa’ t’appresti
e vedrai gente con cui per l’adrieto
gran conoscenza e gran pratica avesti — .
Indi levossi, e io le tenni drieto,
com’ella volse, e non senza paura;
pur non sembrava né mesto né lieto.
Fatta era già la notte ombrosa e scura;
ond’ella prese una lanterna in mano,
ch’a suo piacer il lume scuopre e tura.
Giti che fummo, e non molto lontano,
mi parve entrar in un gran dormitoro,
sì come ne’ conventi usar veggiàno.
Un landrone era proprio come il loro,
e da ciascun de’ lati si vedeva
porte pur fatte di pover lavoro.
Allor la donna ver me si volgeva,
e disse come dentro a quelle porte
il grande armento suo meco giaceva.
E perché variata era la sorte,
eran varie le loro abitazioni,
e ciaschedun si sta col suo consorte.
Stanno a man destra, al primo uscio i leoni,
cominciò, poi che ’l suo parlar riprese,
— co’ denti acuti e con gli adunchi unghioni.
Chiunque ha cor magnanimo e cortese,
da Circe in quella fera si converte;
ma pochi ce ne son del tuo paese.
Ben son le piagge tue fatte deserte
e prive d’ogni gloriosa fronda,
che le facea men sassose e meno erte.
S’alcun di troppa furia e rabbia abbonda,
tenendo vita rozza e violenta,
tra gli orsi sta ne la stanza seconda;
e ne la terza, se ben mi rammenta,
voraci lupi e affamati stanno,
tal che cibo nessun non gli contenta.
Lor domicilio nel quarto loco hanno
buffoli e buoi; e se con quella fiera
si truova alcun de’ tuoi, àbbisi il danno.
Chi si diletta di far buona ciera
e dorme quando e’ veglia intorno al fuoco,
si sta fra’ becchi nella quinta schiera.
Io non ti vuo’ discorrere ogni loco:
perché a voler parlar di tutti quanti,
sarebbe il parlar lungo e ’l tempo poco.
Bàstiti questo: che dietro e davanti
ci son cervi, pantere e leopardi,
e maggior bestie assai che leofanti.
Ma fa ch’un poco al dirimpetto guardi
quell’ampia porta ch’a l’incontro è posta,
ne la quale entrerem, benché sia tardi. —
E prima ch’io facessi altra risposta,
tutta si mosse, e disse: — Sempre mai
si debbe far piacer quando e’ non costa.
Ma perché, poi che dentro tu sarai,
possa conoscer del loco ogni effetto
e me’ considerar ciò che vedrai,
intender debbi che, sotto ogni tetto
di queste stanze, sta d’una ragione
d’animai bruti, come già t’ho detto.
Sol questa non mantien tal condizione,
e, come avvien nel Mallevato vostro
che vi va ad abitar ogni prigione,
così colà in quel loco ch’io ti mostro,
può ir ciascuna fiera a diportarsi,
che per le celle stan di questo chiostro;
tal che, veggendo quella, potrà farsi,
senza riveder l’altre ad una ad una,
dove sarebbon troppi passi sparsi.
E anche in quella parte si raguna
fiere che son di maggior conoscenza,
di maggior grado e di maggior fortuna.
E se ti parran bestie in apparenza,
ben ne conoscerai qualcuna in parte
a’ modi, a’ gesti, a gli occhi, a la presenza.
Mentre parlava, noi venimmo in parte
dove la porta tutta ne appariva,
con le sue circostanze a parte a parte.
Una figura, che pareva viva,
era di marmo scolpita davante
sopra ’l grande arco che l’uscio copriva:
e come Annibal sopra un elefante,
parea che trionfasse; e la sua vesta
era d’uom grave, famoso e prestante.
D’alloro una ghirlanda aveva in testa;
la faccia aveva assai gioconda e lieta;
d’intorno, gente che li facean festa.
Colui è il grande abate di Gaeta,
disse la donna, come saper dei,
che fu già coronato per poeta.
Suo simulacro da’ superni Dei,
come tu vedi, in quel loco fu messo,
con gli altri che gli sono intorno a’ piei,
perché ciascun che gli venisse appresso,
senz’altro intender, giudicar potesse
quai sian le genti là serrate in esso.
Ma facciam sì omai, ch’io non perdesse
cotanto tempo a risguardar costui,
che l’ora del tornar sopragiungesse.
Vienne, adunque, con meco; e se mai fui
cortese, ti parrò a questa volta,
nel dimostrarti questi luoghi bui,
se tanta grazia non m’è dal ciel tolta.
Capitolo settimo ⮵
Noi eravam col piè già ’n su la soglia
di quella porta, e di passar là drento
m’avea fatto venir la donna voglia;
e di quel mio voler restai contento,
perché la porta subito s’aperse,
e dimostronne il serrato convento.
E perché me’ quel potesse vederse,
il lume ch’ella avea sotto la vesta
chiuso, ne l’entrar là tutto scoperse.
A la qual luce sì lucida e presta,
com’egli avvien nel veder cosa nuova,
più che duemila bestie alzar la testa.
Or guarda ben, se di veder ti giova,
disse la donna, il copioso drappello
che ’n questo loco insieme si ritruova.
Né ti paia fatica a veder quello,
ché non son tutti terrestri animali;
ben c’è tra tante bestie qualche uccello.
Io levai gli occhi, e vidi tanti e tali
animai bruti, ch’io non crederei
poter mai dir quanti fossero e quali;
e perché a dirlo tedioso sarei,
narrerò di qualcun, la cui presenza
diede più maraviglia a gli occhi miei.
Vidi un gatto per troppa pazienza
perder la preda, e restarne scornato,
benché prudente e di buona semenza.
Poi vidi un drago tutto travagliato
voltarsi, senza aver mai posa alcuna,
ora sul destro ora su l’altro lato.
Vidi una volpe, maligna e ’mportuna,
che non truova ancor rete che la pigli;
e un can còrso abbaiar a la luna.
Vidi un leon che s’aveva gli artigli
e’ denti ancor da se medesmo tratti,
pe’ suoi non buoni e non saggi consigli.
Poco più là, certi animai disfatti
qual coda non avea, qual non orecchi,
vidi musando starsi quatti quatti.
Io ve ne scorsi e conobbi parecchi;
e, se ben mi ricordo in maggior parte,
era un mescuglio fra conigli e becchi.
Appresso questi, un po’ così da parte,
vidi un altro animal, non come quelli,
ma da natura fatto con più arte.
Aveva rari e delicati e’ velli;
parea superbo in vista e animoso,
tal che mi venne voglia di piacelli.
Non dimostrava suo cuor generoso,
Gli ugnoni avendo incatenato e i denti;
però si stava sfuggiasco e sdegnoso.
Una . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vidi . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poi vidi una giraffa, che chinava
il collo a ciascheduno; e da l’un canto
aveva un orso stanco che russava.
Vidi un pavon col suo leggiadro ammanto
girsi pavoneggiando, e non temeva
se ’l mondo andasse in volta tutto quanto.
Uno animal che non si conosceva,
sì variato avea la pelle e ’l dosso,
e ’n su la groppa una cornacchia aveva.
Una bestiaccia vidi di pel rosso,
ch’era un bue senza corna; e dal discosto
m’ingannò, che mi parve un caval grosso.
Poi vidi uno asin tanto mal disposto,
che non potea portar, non ch’altro il basto;
e parea proprio un citriuol d’agosto.
Vidi un segugio, ch’avea il veder guasto:
e Circe n’arìa fatto capitale,
se non foss’ito, com’un orbo, al tasto.
Vidi uno soricciuol, ch’avea per male
d’esser sì piccoletto, e bezzicando
andava or questo, or quell’altro animale.
Poi vidi un bracco, ch’andava fiutando
a questo il ceffo a quell’altro la spalla,
come s’andasse del padron cercando.
Il tempo è lungo, e la memoria falla;
tanto ch’io non vi posso ben narrare
quel ch’io vidi in un dì per questa stalla.
Un buffol, che mi fe’ raccapricciare
col suo guardare e ’l suo mugliar sì forte,
d’aver veduto i’ mi vo’ ricordare.
Un cervio vidi, che temeva forte,
or qua or là variando il cammino,
tanto avea paura de la morte.
Vidi sopra una trave un armellino,
che non vuol ch’altri il guardi, non che ’l tocchi,
ed era a una allodola vicino.
In molte buche più di cento allocchi
vidi, e una oca bianca come neve
e una scimia che facea lo ’mbocchi.
Vidi tanti animai, che saria greve
e lungo a raccontar lor condizioni,
come fu il tempo a riguardarli breve.
Quanti mi parver già Fabi e Catoni,
che, poi che quivi di lor esser seppi,
mi riusciron pecore e montoni!
Quanti ne pascon questi duri greppi,
che seggono alto ne’ più alti scanni!
Quanti nasi aquilin riescon gheppi!
E bench’io fossi involto in mille affanni,
pur parlare a qualcuno arei voluto,
se vi fossero stati i torcimanni;
ma la mia donna, ch’ebbe conosciuto
questa mia voglia e questo mio appetito,
disse: — Non dubitar, ch’e’ fia adempiuto.
Guarda un po’ là dov’io ti mostro a dito,
senz’esserti più oltre mosso un passo
pur lungo il muro, come tu se’ ito. —
Allora io vidi entro in un luogo basso,
com’io ebbi ver lui dritto le ciglia,
tra ’l fango involto un porcellotto grasso.
Non dirò già chi costui si somiglia;
bàstivi ch’e’ saria trecento e piue
libbre, se si pesasse a la caviglia.
E la mia guida disse: — Andiam là giue
presso a quel porco, se tu se’ pur vago
d’udir le voglie e le parole sue.
Che se trar lo volessi di quel lago,
facendol tornar uom, e’ non vorrebbe;
come pesce che fosse in fiume o in lago.
E perché questo non si crederebbe,
acciò che far ne possa piena fede,
domandera’lo se quindi uscirebbe.
Appresso mosse la mia donna il piede;
e per non separarmi da lei punto,
la presi per la man ch’ella mi diede;
tanto ch’io fui presso a quel porco giunto.
Capitolo ottavo ⮵
Alzò quel porco al giunger nostro il grifo,
tutto vergato di meta e di loto,
tal che mi venne nel guardarlo a schifo.
E perch’io fui già gran tempo suo noto,
ver me si mosse mostrandomi i denti,
stando col resto fermo e senza moto.
Ond’io li dissi, pur con grati accenti:
— Dio ti dia miglior sorte, se ti pare;
Dio ti mantenga, se tu ti contenti.
Se meco ti piacesse ragionare,
mi sarà grato; e perché sappia certo,
pur che tu voglia, ti puoi sodisfare.
E per parlarti libero e aperto,
tel dico con licenza di costei,
che mostro m’ha questo sentier deserto.
Cotanta grazia m’han fatto li Dei,
che non gli è parso il salvarmi fatica
e trarmi degli affanni ove tu sei.
Vuole ancor da sua parte ch’io ti dica
che ti libererà da tanto male,
se tornar vuoi ne la tua forma antica. —
Levossi allora in piè dritto il cignale,
udendo quello; e fe’ questa risposta,
tutto turbato, il fangoso animale:
Non so d’onde tu venga, o di qual costa;
ma se per altro tu non se’ venuto
che per trarmi di qui, vanne a tua posta.
Viver con voi io non voglio, e rifiuto;
e veggo ben che tu se’ in quello errore,
che me più tempo ancor ebbe tenuto.
Tanto v’inganna il proprio vostro amore,
che altro ben non credete che sia
fuor de l’umana essenza e del valore;
ma se rivolgi a me la fantasia,
pria che tu parta da la mia presenza,
farò che ’n tale error mai più non stia.
Io mi vo’ cominciar da la prudenza,
eccellente virtù, per la qual fanno
gli uomin maggiore la loro eccellenza.
Questa san meglio usar color che sanno,
senz’altra disciplina, per sé stesso
seguir lor bene ed evitar lor danno.
Senz’alcun dubbio, io affermo e confesso
esser superior la parte nostra;
e ancor tu nol negherai appresso.
Qual è quel precettor che ci dimostra
l’erba qual sia, o benigna o cattiva?
Non studio alcun, non l’ignoranza vostra.
Noi cangiam region di riva in riva,
e lasciare uno albergo non ci duole,
pur che contento e felice si viva.
L’un fugge il ghiaccio e l’altro fugge il sole,
seguendo il tempo a viver nostro amico,
come natura che ne insegna, vuole.
Voi, infelici assai più ch’io non dico,
gite cercando quel paese e questo,
non per aere trovar freddo od aprico,
ma perché l’appetito disonesto
de l’aver non vi tien l’animo fermo
nel viver parco, civile e modesto;
e spesso in aere putrefatto e infermo,
lasciando l’aere buon, vi trasferite;
non che facciate al viver vostro schermo.
Noi l’aere sol, voi povertà fuggite,
cercando con pericoli ricchezza,
che v’ha del ben oprar le vie impedite.
E se parlar vogliam de la fortezza,
quanto la parte nostra sia prestante
si vede, come ’l sol per sua chiarezza.
Un toro, un fer leone, un leofante
e ’nfiniti di noi nel mondo sono
a cui non può l’uom comparir davante.
E se de l’alma ragionare è buono,
vedrai di cori invitti e generosi
e forti esserci fatto maggior dono.
Tra noi son fatti e gesti valorosi
senza sperar trionfo o altra gloria,
come già quei Roman che fur famosi.
Vedesi ne’ leon gran vanagloria
de l’opra generosa, e de la trista
volerne al tutto spegner la memoria.
Alcuna fera ancor tra noi s’è vista,
che, per fuggir del carcer le catene,
e gloria e libertà morendo acquista;
e tal valor nel suo petto ritiene
ch’avendo perso la sua libertate,
di viver serva il suo cor non sostiene.
E se a la temperanza risguardate,
ancora e’ vi parrà ch’a questo gioco
abbiam le parti vostre superate.
In Vener noi spendiamo e breve e poco
tempo; ma voi, senza alcuna misura,
seguite quella in ogni tempo e loco.
La nostra specie altro cibar non cura
che ’l prodotto dal ciel sanz’arte, e voi
volete quel che non può far natura.
Né vi contenta un sol cibo, qual noi,
ma, per me’ sodisfar le ’ngorde voglie,
gite per quelli infin ne’ regni Eoi.
Non basta quel che ’n terra si ricoglie,
ché voi entrate a l’Oceano in seno,
per potervi saziar de le sue spoglie.
Il mio parlar mai non verrebbe meno,
s’io volessi mostrar come infelici
voi siete più ch’ogni animal terreno.
Noi a natura siam maggiori amici;
e par che in noi più sua virtù dispensi,
facendo voi d’ogni suo ben mendici.
Se vuoi questo veder, pon mano a’ sensi,
e sarai facilmente persuaso
di quel che forse pe ’l contrario pensi.
L’aquila l’occhio, il can l’orecchio e ’l naso,
e ’l gusto ancor possiam miglior mostrarvi,
se ’l tatto a voi più proprio s’è rimaso;
il qual v’è dato non per onorarvi,
ma sol perché di Vener l’appetito
dovesse maggior briga e noia darvi.
Ogni animal tra noi nasce vestito:
che ’l difende dal freddo tempo e crudo,
sotto ogni cielo e per qualunque lito.
Sol nasce l’uom d’ogni difesa ignudo,
e non ha cuoio, spine o piume o vello,
setole o scaglie, che li faccian scudo.
Dal pianto il viver suo comincia quello,
con tuon di voce dolorosa e roca;
tal ch’egli è miserabile a vedello.
Da poi, crescendo la sua vita è poca,
senz’alcun dubbio, al paragon di quella
che vive un cervo, una cornacchia, un’oca.
Le man vi diè natura e la favella,
e con quelle anco ambizion, vi dette,
e avarizia che quel ben cancella.
A quante infermità vi sottomette
natura, prima, e poi fortuna! Quanto
ben senz’alcun effetto vi promette!
Vostr’è l’ambizion lussuria e ’l pianto,
e l’avarizia che genera scabbia
nel viver vostro che stimate tanto.
Nessun altro animal si trova ch’abbia
più fragil vita, e di viver più voglia,
più confuso timore o maggior rabbia.
Non dà l’un porco a l’altro porco doglia,
l’un cervo a l’altro; solamente l’uomo
l’altr’uom ammazza, crocifigge e spoglia.
Pens’or come tu vuoi ch’io ritorni uomo,
sendo di tutte le miserie privo,
ch’io sopportava mentre che fui uomo.
E s’alcuno infra gli uomini ti par divo,
felice e lieto, non gli creder molto,
ché ’n questo fango più felice vivo,
dove senza pensier mi bagno e vòlto. —
James Mew: Macchiavellis “Golden Ass” ⮵
The Church of Santa Croce, says Byron in one of his letters, contains much illustrious nothing. There, in the Westminster Abbey of Italy, in the good society of Michael Angelo, Galileo, and Alfieri, lie the particles which have relapsed to chaos of the sublime Nicolo Macchiavelli. Doubt clings about him like a garment, and begins with the spelling of his name. Its orthography, like that of Shakespeare, is unsettled. Byron may be right in spelling it Niccolo Machiavelli, but he is certainly wrong in finding fault with his monument for containing no information about the time of his death, The Obiit Anno A.P.V. MDXXVII. is distinct. It was erected, according to one authority, by the Grand Duke Leopold; according to another, by a certain Lord Nassau-Clavering Count Cowper. Such are the contradictions clustering about a man whose fate it seems was to be misunderstood. For two centuries and a half he was thought unworthy of any lapidary notice whose sepulchre now bears the line —
Tanto nomini nullum par elogium,
Up to the present period, nevertheless, that name has been oppressed by the weight of a popular anathema maranatha, and the able and devoted patriot, whose sweetest dream was the unity and liberty of his country, has been stigmatised as the laureate of cruelty and falsehood. It was, as Moore says, ever thus. Even in the age of Elizabeth we find two of his greatest contemporaries speaking of him in opposite terms. With Shakespeare he is all that is bad. The great poet but reflects the popular verdict when, in the “Merry Wives of Windsor,” mine host of the Garter Inn uses his name as the synonym of subtlety and fraud; or again, when, in the third part of Henry VI., Gloucester talks of setting the murderous Machiavel to school. Bacon, on the other hand, thinks him worthy of all thanks and praise, and in his De Augmentis chronicles the debt due to him from mankind as one of those who have openly, and without dissimulation, shown us not what men ought to do, but what they do. With the character of Machiavelli this paper is not concerned. Whether he wrote with the finger of Satan, as a church dignitary, with more indignation than intelligence, affirmed, it does notconsider; it is occupied only with one of his works.
Some sort of biography is, however, de rigueur, whether its author be regarded as a man or an artist, as a diplomatist or a poet. It is well to make it as short as may be. Nicolo Macchiavelli, or Macchiavegli, as his name was originally, perhaps — for in this matter of spelling all is uncertain — spelt, was born in Florence in 1469, and there “his earth retuned to whence it rose.” He is supposed to have died of despair or poison. This matter, like many another circumstance in his life’s story, is, as Milton says, a “covered field,” in which his biographers delight to combat. He was married, probably, from his novel of “Belphegor,” unhappily, but this too is not sure, and had five children. He was of middle height, and his complexion was dark and adust as that of the hero of Cervantes. He was secretary of the ten magistrates of liberty and peace in the little republic of Florence for fifteen years, and so is commonly called the Florentine Secretary. He wrote official letters, registered the decrees of the executive, and was despatched on some five-and-twenty diplomatic matters, of which he has given a full account in his “Legations.” He held, in fact, the supreme power in his native town. On the return of the Medici he was banished, and possibly tortured — another bone for biography. Certainly, he says in a letter to one of his friends, that it is a miracle he is alive, and that it is only God and his innocence that have saved him. He complains of the ills of imprisonment, but speaks in no explicit terms of torture. Compulsory leisure bore to him literary fruit, as it bore to Milton. The evil wind of exile, if it be an evil wind, blew him the good, if it be a good, of an immortal fame. His political labours left him little leisure for literary composition. He had written nothing, save a few poems and the “Legations.” But in the first year of his banishment he composed for the world that celebrated work with which his name is chiefly associated, a work so often quoted and so seldom read, the celebrated “Prince,” which has been held now a satire against tyrants, and now a manual of tyranny. The same year also produced his “Treatise on the Art of War.” In the next he wrote his “Discourses on Livy,” which, with “The Prince,” form his two political chefs d’œuvre, These prove his right to the title of an illustrious statesman, as his Florentine histories to that of an eminent historian. But Nicolo Macchiavelli was an universal genius. He possessed an extraordinary flexibility of talent. Besides his works on politics, history, diplomacy, and war, he wrote several capital comedies, and a philosophic tale, not unworthy of Boccaccio, and admitted a model of Italian prose. He also wrote saome poems, among which that of the “Golden Ass” is pre-eminent. It lies among them, however, neglected and forgotten. Those of the Italian critics who have noticed it, have spoken of it, almost without exception, in terms of fervent praise. Macaulay calls it “not altogether destitute of merit,” allows it considerable ingenuity in its allegory and some colouring in its descriptions, but there an end. To damn with praise, just hint a fault and hesitate dislike, was not the exclusive province of Addison. Machiavelli cannot, indeed, be placed as a poet in the first rank either with Dante or with Ariosto. Like Cervantes or Muhammad, he was fond of poetry, and sought by study to become a poet. But poetry is a gift of the gods. This truth in the case of the Arabic legislator is recognised in a Surat of the Koran — “We have not taught him poetry, neither does it suit him.” Still, the “Golden Ass” has sometimes poetic charms, and many times charms of another category.
In the last canto of the “Orlando Furioso,” the poet of Ferrara congratulates himself on the happy conclusion of his work. I am, he says, if my chart be correct, hard by my harbour, and must soon pay my vows upon the shore. He imagines with ingenuous modesty a scene of general satisfaction. Fair ladies and brave men crowd the landing-place to welcome his return. On every available jut or coigne of vantage is perched some prince or poet to do him honour. Here is the beautiful Ippolita Sforza, to whom Bandello dedicated his first novel, and there is the learned and ill-fated Julia Gonzaga. Here is the divine poet, the scourge of kings, Pietro Aretino, and there Jacobo Sannazar, who brought down the muses from the high mountain to the sandy plain. He speaks of a Nicolo Tiepoli, and a Nicolo Amaino, more remarkable, both of them, from the regard of Ariosto than for their own rhymes, but never a word says he about Nicolo Macchiavelli. The Florentine secretary seems to have taken umbrage at the omission. In a letter to Lodovico Alamanni, written a little before the Christmas of 1517, we read: “I have seen Ariosto’s poem, and think it a beautiful work throughout, and in some parts an admirable one. Commend me to the author, if he be in Rome, and tell him my sole regret is, that having mentioned so many poets, he has left me out as a — , and that he has done for me in his ‘Orlando’ what I will not do for him in my ‘Ass.’” The blank, hiatus valde deflendus, in this epistle is due to the delicate and amiable care of some worthy Bowdler, whose conscientious scruples led him to efface for the welfare of posterity whatever in the collected MSS. of Macchiavelli seemed to his omniscient judgment free or irreligious, sarcastic or impure. The good man did his work so effectually, by scratching out with a knife, as to make the unhappy letters look like a Gruyère cheese, and to set all hope of restoring their text at an infinite distance. What Macchiavelli did for Ariosto in the “Ass,” it is not easy to determine. He may have intended to say something about him in those chapters of the poem which were unhappily never written, or he may have forgotten all about his promise, like Ginguené, who, after considering the other works of our author, tells his readers he will speak elsewhere of the “Golden Ass,” but never does so. However, the letter gives at least some sort of a clue to the date of the composition of the poem. It was certainly written after what is called his disgrace, and was his disillusion, dans les sentiers déserts de San-Casciano, where, as De Musset says in his Vœux Stériles, the sound of his footsteps echoes still under the burning skies.
The “Golden Ass” is evidently built after the model of Dante’s “Inferno.” It corresponds with it in form, and matter, and end. It is composed in Dante's tercets, Macchiavelli's favourite verse. Its style is energetic and rough, as the style of Dante; its situations are often parallel to the situations of Dante, and the words not infrequently are Dante's own words. It is indeed humble as the Divine Comedy is sublime. The first colloquy of Dante after his speech to Virgil, his guide, is with the fair Francesca. Macchiavelli’s first conversation after a talk with his guide is with a filthy pig. The “Ass” has therefore been regarded as a parody of the “Inferno.” Macchiavelli, indeed, had censured Dante for calling the language of his poem Curial instead of Florentine, and differed from him widely in his view of the respect owing to their common country. Perhaps there is not enough of the poem to determine its true nature. It is a mere fragment of eight cantos or chapters, as the author calls them; only a prelude to the fuller music which might have been. There is no trace in it of any transformation of the author into an ass. It has, therefore, little except in name to do with the works of Lucian and Apuleius, with which it has nevertheless been compared by some of that large class of critics who are able, probably by what Professor “Tyndall calls a scientific use of the imagination, to write criticisms of pages they have never read. It is not Addison alone who can evolve: out of his inner consciousness a very confident and discriminative character of Spenser without having read a line of him. The “Golden Ass” bears, as far as it goes, rather a relation to the Homeric tale of “Circe.” The author proposés to sing the pain and sorrow he suffered under the form of an ass, but as an ass he never appears. There is no more mention of him in that character than of Orlando in the first seven books of Ariosto's famous song, or of the Fairy Queen in Spenser's poem. He will not ask Apollo to accompany him with the lyre for two reasons — first, that he would obtain nothing by his request; and second, that the accompaniment of a bray would spoil the harmony of the instrument. The strong force of mind and complete indifference to public opinion which ever distinguished him makes him say that he cares little for praise or blame, open or concealed, and confess his intention of sprinkling some of the poison of satire at a time when its proper objects are so numerous — a heavy and despiteful time, when, without needing the eyes of Argus, one may see evil much sooner than good. Heaven itself shall not prevent his braying in such an hour.
The season of the poem is spring, the days when Dian begins her hunt. The poet finds himself in a wild wood at nightfall. Fear and darkness prevent his going farther, when he hears suddenly the harsh blast of a horn, and sees a sudden light. Soon a beautiful lady appears, with golden dishevelled hair, surrounded by a countless crowd of brutes of many kinds. The lady, with a simper, bids him good-evening as familiarly as though she had seen him a thousand times. She is one of the handmaidens of Circe, who, before Jove held his state, was compelled to abandon her ancient nest, and fled in avoidance of all human consort to this umbrageous wood. Here, hating mortals, and by them in turn hated, fed with the heavy sighs of this mighty drove, every beast of which was once a man, she holds her sad and solitary reign. This is all the description in the poem of Homer’s “Circe,” that fair-haired daughter of the sun, in the vestibule of whose house stood lions wagging their tails, and strong-taloned wolves, while the goddess within sang with her silver voice, sitting before her loom. Macchiavelli, as will be seen, sets the servant in the place of the mistress, of whom there is no more mention. Some of the herd lock at the poet as though to show him they too had once been men, and lick his feet for very sympathy of sorrow. Lest his human shape should be seen, Machiavelli crawls on all-fours beneath the shoulders of a stag and of a bear, and so, like Ulysses in the Cyclops’ cave, follows the footsteps of her he calls — as Tristram Shandy called Fortune — his Duchess. After wading through a wet ditch, which his guide passes by means of a bridge, he comes to a lofty palace. His Duchess then stables her herd, and, taking him by the hand, leads him into her private room, where she kindles a large fire to dry his dripping clothes. He tells her she has saved his life, and that in her face he sees his supreme good. The Duchess replies that no one in ancient or modern times has ever suffered more ingratitude or greater hardship than Nicolo Macchiavelli. This, however, is not his own. fault, but that of fortune. There is nothing in the world that remains constant. All things are like heaven, now dark, now clear; all like the moon and stars, for ever moving without repose. Hence come peace and war, and the enmities of those in the same city. Happy times will return, wherein the poet may rejoice to tell the story of his past sufferings, but before these times Providence will have him, for his own good, changed into the form of a brute. Hitherto all things have been more or less gloomy; but after this comes a sudden change of style. Instead of a lurid Rembrandt, we have a smiling landscape of Lorraine, or rather a homely interior of Ostade. A cloth is spread on a table by the fireside, and a loaf, a fowl, a ready-dressed salad, and a decanter of excellent wine are produced from a convenient cupboard; for, says the Duchess, not without reason, to the poet, after kissing him ten times with open arms, if your constitution is not of steel, you will need a little refreshment. The poet having partaken, to borrow a flower from the occasional reporter, of refreshment, falls to describing the beauty of his hostess, to do which he is compelled after all to call on the aid of the Muses; and that lyre of Apollo, which he refused to ask for in the beginning of his poem, might have been useful in this emergency. Her hair is golden like a star’s rays, Each eye is a flash of fire, extinguishing all mortal sight. No other hand than that of Jove could have fashioned her mouth. All the gods of heaven must have joined to frame her eyebrows. Her tongue quivers like a serpent between her lips and teeth. Her words make the grass grow and arrest the wind. For the rest of the description, and the concluding conversation of the night, Macchiavelli himself had some doubts about mentioning it. In these matters, he says, truth generally makes war against those who speak it. Still, the idea that a pleasure unrecorded is only half a pleasure, induces him to write some of the finest and most Dantesque verses in the poem, verses more passionate than those of Ariosto, equally gracious and sweet with those of Tibullus and Ovid, verses which, harmonising with the barbarous notions of modesty and imperfect ideas of delicacy of his age, cannot of course be now quoted. The cold night wanes, star after star pales and goes out, and the field of heaven is white when the Duchess leaves the poet to look after her drove. Alone, his mind reverts to past events, not yet hidden by the veil of time. In a word, he forgets both joys and sorrows in a political diatribe. Thecause of the changing fortune of states and kingdoms is the fact that the powerful are never satisfied with their power — Venice is an example. It had been better for St. Mark had he kept his back and tail under water. Athens and Sparta are other examples. They prepared their own ruin by that of others. Empires which begin in Ninus the divine, end in the effeminate Sardanapalus. Valour begets ease, ease disorder, disorder valour, and so on in a perpetual cycle. It has been, it is, and it always will be the case that evil grows out of good, and good out of evil. Macchiavelli is so fond of this axiom, that he has twice inserted it in this one poem. In the mean time the East blackens, and the sound of the distant horn announces the Duchess’s return home. The remainder of the “Golden Ass” is a flagrant imitation of the “Inferno.” The Duchess takes Nicolo by the hand as Virgil Dante, for Circe’s meretricious handmaiden can hardly be compared with the modest celestial Beatrice, and by the aid of a dark lantern,
Che a suo piacere il Iume scopre e tura,
discovers a long corridor, like that of a convent dormitory, at the end of which is the beasts’ common-room. Over its entrance is a figure in marble of the Abbot of Gaeta, with a garland on his head, riding like a triumphant Hannibal on a mighty elephant. There is little doubt that the author alluded to one Baraballo, a common tale of the time, for his métromanie, to whom the festive Leo X. accorded, about a couple of years before the probable date of the poem, a mock ceremonial procession, in honour of his verse, through the streets of Rome. “His figure,” says the Duchess, “is placed here to show the sort of people inside, Among them you will find many you knew well in the past.” Coupling with this sentence the fact that Baraballo is also carved in wood on the door of one of the inner chambers of the Vatican, the reader may form his own conclusions as to the sort of beasts now offered in this ancient menagerie to the author’s view. They are in number over two thousand. Among them is a prudent well-born cat, who allowed by negligence his prey to escape him; a wolf not to be taken by any net; a dog barking at the moon; a lion who has in his folly drawn his own teeth and claws, an operation probably of some little difficulty; a giraffe, an animal then lately introduced, bending his long neck to one and all; a snoring bear a short-sighted blood-hound; a snow-white goose; some hundred owls; an ermine, who would allow none to look at him far less touch him, sitting by the side of a lark; a peacock letting the world slide while he admires the glory of his tail; and an ass not able to bear his own saddle, like a cucumber in August. But the greatest part of the beasts are a mixture between a rabbit and a goat. A couple of stanzas are here omitted in all editions, probably owing to the exertions of some great man who had suffered from their sting. To this satire of Macchiavelli’s on his contemporaries, contemporary malice lent a charm it no longer possesses. With the factions of the Medici its main interest, and indeed intelligibility, is gone. But, as Voltaire said, he who possessed the key to this apocalypse would be the master of the secret history of Florence of that time. With a sigh the poet sees how many a man, who appeared to him a Fabius or a Cato, is here the merest silly sheep. But he turns and beholds a fat hog over three hundred pounds in weight, whose face is streaked with mud and dung. Him, too, he claims in sorrow as an old acquaintance, and into his mouth is put, half in jest, half in earnest, the most remarkable and piquant idea in the poem, an able development of the paradox, that brutes are better off than men, In Plutarch’s commentary about the comparative skill of land animals and water animals, all brutes are credited with reason and intelligence, but weak and turbid as the sight of a dull and mist-affected eye. In a conversation by the same author, between Ulysses, Circe, and Gryllus, the goddess, after twitting the Cephallenian king with his silly preference of an old woman and misery to herself and immortality, allows him to offer Gryllus an opportunity of regaining his human form. The good Gryllus, however, is so far from wishing to become a man, that he censures Ulysses for not becoming a pig. That cunning hero he compares to a pecvish child, who refuses to be made whole by medicine. “I,” says Gryllus, “have tried both existences, and ought to know which is the better.” He then shows that man is far inferior to the beast in the three cardinal virtues, prudence, and justice, and fortitude. Gryllus, for example, spurns as common stone that gold and silver for which men commit all wickedness, and Gryllus sleeps more sweetly, when full of food, on a heap of soft deep dung, than on a bed rich with purple tapestry and stiff brocade.“Away, then,” he concludes, “and leave me to a life affluent in means, nor seek to persuade me to become again a man, than whom no animal is more prone to misery.” The conversation is unhappily unfinished, but, so far as it goes, Gryllus decidedly has the best of it. Some of the arguments of the metamorphosed Greek the fat and filthy hog repeats to Macchiavelli in this poem, and adds more of his own. Has man, he asks, the eye of the eagle? or the nose or ear of the dog? Is he provided with any natural defence? Does he not begin his life in tears, which no pig does; and what is that life in length, compared to the life of the stag, the rook, or the goose? True, man has head and speech, but has he not also ambition and avarice? One pig injures not another, but man is robbed, clubbed to death, and crucified by man. “How then,” concludes this wise pig, “should I desire to become again a man, being free of all the miseries I endured in my human form? Believe me, however rich, and happy,an divine man’s state may seem, I live far happier in this mud, wherein I bathe and wallow at my ease.” Such is the strange conclusion of the unfinished “Golden Ass.” It becomes silent, like Herodotus, just when our curiosity is most excited. With the moral philosophy of the last chapter we may well compare that part of Pope’s Essay on Man, in which he places instinct, which Addison called the immediate education of Providence, above reason; the volunteer instinct which needs no pope nor council, and must go right above the pressed reason, which does unwilling work and may go wrong. Fénelon and La Fontaine have also given some excellent sentences on this subject. The fabulist has extended the canvas of his predecessors. No pig appears, but Ulysses, the representative of human wisdom, offers enfranchisement to lion,a bear, and a wolf, They all with one accord begin to make excuse. “Shall I, the king of the woods, become a citizen of Ithaca?” answers the lion. “Am I so ugly in the eyes of my mistress; and who made you a judge of shape?” replies the bear. But the best response by far is that of the wolf, who, being charged with the slaughter of divers muttons, says sarcastically, “Should I then love carnage less were I a man? No, all things considered, I maintain
“Que scélérat pour scélérat,
Il veut mieux être un loup qu’un homme.”
The good Archbishop of Cambray, for his part, confesses that men would indeed be worse off than beasts if they were not sustained by the only true religion. Man’s sublime hopes are not shared, in the opinion of the archbishop, by beasts. He claims a sole exclusive heaven for man, an immortality in which no part or lot is to be allowed to any lion, or pig, or wolf, or bear. The archbishop’s pig, a pious pig, an animal evidently not altogether lost, confesses the seductions of a Christian after-life, but laughs to open scorn the pagan elysium of Greece and Rome. In other respects he differs little from the pig of Machiavelli. His French education leads him, however, to attach greater importance to externals. His figure, he confesses, may be loathsome, but then he has no vanity leading him to look into a glass. Nay, he prefers even a muddy pool. He needs no barber; he is clothed without a tailor, and fed without a cook, He cares not, like Diogenes, a fig for his fatherland; every country where an acorn can be found is his native country. On being reminded that pigs must die, he wishes to know if men are immortal? The Circe of Gelli was written after Machiavelli’s work. It was often reprinted in the 16th century, and is remarkable for its natural simplicity of style. It is composed of ten dialogues, in every one of which Ulysses endeavours to persuade some animal to accept of Circe’s offer of restoration to a human shape. In the first dialogue he engages with an oyster and a mole, in the next with a serpent; then with a hare, a goat, a hind, a bear, a horse, a dog, a calf, and an elephant. He is only successful in his last encounter. Only the elephant consents to become again a man. As for the oyster, the proposal disgusts him. His great pride is in his house. He can move it at pleasure, it needs no repair, and he pays no rent. He speaks with some terror lest the sea-crabs, seeing his shell open, should seize the opportunity to throw in a small stone, and thus prevent it shutting, for certain nefarious ends of their own. When Ulysses reproaches him with his little power of locomotion, he inquires why he should wish to move, when he has nothing to move for? In short, he would sooner die than change his state. Ulysses determines to let him remain in his misery as a just reward for his folly, and turns to the mole, to whom he sets forth the advantages of sight. “I,” answers the mole, “for my part, have no need nor desire to see.” Then, says the wisest of the Greeks in a pet, you ought to have, and turns to the serpent. Finding him equally ungrateful, and stopping his ears to his kind offers, Ulysses accuses Circe of having given the beast a voice indeed, but no brains. The women are no whit better than the men. The graceful hind is delighted at the notion of being able to talk again, but deems even that delight too dearly bought by the ills of human existence. She laments the injustice with which her sex is treated, and, beginning with Milton’s assertion that women were “intended first, not after made occasionally,” utters more metaphysics than ladies happily are wont to utter. Much of Gelli’s matter is derived from Plutarch, but his introduction of the feminine element is original and peculiar. Spenser may have seen this work. The reader will remember how Sir Guyon’s Palmer in the “Fairy Queen,” after the overthrow of the Bower of Bliss and the defeat of Acrasia, is roundly abused by Gryll for his retransformation. Nor can the present age of scientific wonders, advanced civilisation, and moral, political, and educational reform produce any alteration in Gryll’s mind, who, in Peacock’s “Gryll Grange,” regards all these as so many changes for the worse, and is still in no mood to feel conviction of our superior greatness.
We have a proverb, that you may bring a horse to the water, but you cannot make him drink. This proverb, with an unimportant variation, dates at least from the days of Macchiavelli. Speaking of the obstinacy of his satire, he excuses it in the beginning of his poem with his imagined form of an ass, of which kind of brutes, he says, one was brought by all the folk of Siena to its fountain Branda to make him drink, and after much difficulty they managed to get half a drop into his mouth. This fountain of Branda is apparently taken from Dante, who represents Master Adam, the coiner, parched with the thirst of dropsy, and yet wishing rather to see in hell as partners of his pain the sad souls of those that had urged him to his crime than to drink of its clear and abundant waters. There are, it has been already affirmed, passages in the “Ass” which are verbal transcripts of passages in the Divine Comedy. Dante, in his eloquent apostrophe in the “Purgatorio,” occasioned by the meeting of Virgil with his compatriot Sordello, says, in detestation of the unnatural quarrels of his people, that one man gnaws another among those who are enclosed by the same moat and the same walls. Macchiavelli introduces this very expression when he attributes the quarrels of people so situated to that necessary mutation and revolution in the nature of things which makes the heavens now dark, now clear. For such a coincidence as this the reader is prepared by the opening lines of the poem, wherein Macchiavelli’s entry into the rough rank forest in fear and darkness of course recalls the commencement of the “Inferno.” How he got into the wood neither poet is able to tell:
I’ nom so ben ridir com’ io v’ entrai,
says Dante, and says Macchiavelli —
Io non vi so ben dir com’ io v’ entrai.
There is, however, this difference in the time, that though both singers sang in the darkness, the darkness of Nicolo is that which precedes the night, but the darkness of the Alighieri that which prevents the dawn.
The “Golden Ass” is not without many beauties. It is philosophical in its observations on man’s misfortunes and the ruin of states; it is poetical in its description of Circe’s handmaiden; it is not seldom moral, and on two occasions distinctly religious; it is replete with common sense. We are always, Macchiavelli says, most inclined to believe those who promise us good; hence the credit of physicians, though we often deprive ourselves of good by believing them. When he adds, however, that this, out of the seven liberal professions, is the only one which feeds and lives on the ill of others, his opinions seem not so correct. The ill of others is certainly also the support of the soldier and the lawyer. The advice given him in his calamity deserves attention. When evil comes — and come it will so long as the world lasts — gulp it down at once like a dose of medicine; he who rolls it on his tongue to taste it is a fool. Some of the religious turns surprise the reader who has been taught to look at the author as little less than an Atheist. My opinion is, he says in the fifth chapter, that the causes of the greatness of states, and what maintains them exalted and powerful, are fastings, alms, and prayers. And a little further on he tells us that prayers are certainly necessary; that he who denies the people their ceremonies and devotions is more than half a fool; that from these is the harvest of union and good order, and that on good order depends our good and happy fortune. Nor is this merely a poetical flourish. In his “Discourses on the First Decade of Livy” he devotes a whole chapter to the importance of religious practices in the preservation of a state, and instances the near ruin of Italy as the result of their neglect. He has similarly supported his poetry and his prose by a chapter in “The Prince,” in which he considers Fortune to have given only one half of our actions to our own management, reserving the direction of the other half for herself. Those who assert that Macchiavelli was the inventor and exponent of the maxim that language was given us to conceal our thoughts, can receive nothing in earnest from that author. But was this maxim, which has ever been urged against him, any of his? Robert Scuth, preaching in Westminster Abbey, in 1676, on the text, “For the wisdom of this world is foolishness with God,” takes occasion to cast his stone at the “great patron and corypheus of politic sages, Nicolas Machiavel,” as one of those declaring that speech was given to the ordinary sort of men whereby to communicate their mind, but to wise men whereby to conceal it. The turn of phrase has beep attributed to Talleyrand, and may be found in many authors. Dr. Young, in one of his “Satires on the Love of Fame,” speaks of the noontide masquerade of court and town,
Where nature’s end of language is declined,
And men talk only to conceal the mind.
Goldsmith made a backbone for one of his “Essays on the Bee” out of the similar thesis, which he held supported by reason, that the true use of speech was not so much to express our wants as to conceal them. Finally, Voltaire, in his Dialogue between “La Poularde et le Chapon,” makes the unhappy capon speak of mankind generally as using their thoughts to authorise their injustice, and their words to disguise their thoughts.
— The Gentleman’s Magazine. January to June 1882. Vol. CCLII. London: Chatto & Windus, 1882. pp. 104-115.
James Mew (1837 – 25 February 1913) was an English barrister and miscellaneous writer: Drinks of the World, 1893; Traditional Aspects of Hell (Ancient and Modern), 1903, and a contributor to the Dictionary of National Biography.